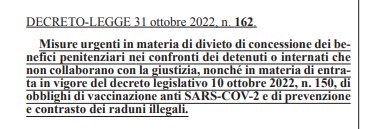«Mi chiamo Elena» (e quell’inutile umiliazione di Marco Cappato)
«Mi chiamo Elena, sono italiana e mi trovo in Svizzera. Un anno fa ho avuto la diagnosi di microcitoma polmonare. Non ho nessun supporto vitale per vivere, solo una cura a base di cortisone. Mi restava solo da aspettare che le cose peggiorassero. Ora, mettendo in pratica una convenzione che avevo già in tempi non sospetti, prima che succedesse tutto questo, ho deciso di terminare la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia stessa. Ho parlato con la mia famiglia, ho avuto la comprensione e il sostegno che potevo desiderare. Ho chiesto aiuto a Marco Cappato».
Elena è morta il 2 agosto in una clinica svizzera, dove è stata accompagnata da Marco Cappato, il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, che oggi si autodenuncerà per aiuto al suicidio, previsto dall’art. 580 cod. pen., che prevede fino a 12 anni di reclusione.
Cappato rischia di finire sotto processo in quanto il caso di Elena non rientrerebbe tra quelli contemplati dalla Corte Costituzionale per il suicidio medicalmente assistito. La donna, infatti, non sarebbe stata tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, requisito richiesto dalla sentenza n. 242/2019 della Consulta per l’aiuto al suicidio.
Secondo la Corte, infatti, non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona (a) tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e (b) affetta da una patologia irreversibile, (c) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, (d) ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, (e) sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
In realtà, come evidenziato da Corte Assise Massa 2-9-2020, “la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non significa necessariamente ed esclusivamente dipendenza da una macchina. Ciò che ha rilevanza sono tutti quei trattamenti sanitari – sia di tipo farmaceutico, sia di tipo assistenziale medico o paramedico, sia infine con l’utilizzo di macchinari, compresi la nutrizione e l’idratazione artificiale – senza i quali si viene ad innescare nel malato un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte”.
Vengono in rilievo, quindi, tutti i trattamenti sanitari che garantiscano al paziente un’aspettativa di vita più lunga (anche solo di poco) rispetto a quella naturale, come la chemioterapia – che, pur senza offrire reali speranze di cura, potrebbe dare al paziente alcuni mesi di vita in più – o terapie a base di cortisone, di antibiotici o di antidolorifici in grado di rallentare il decorso della malattia e migliorare le condizioni di vita del paziente.
Se ci si fermasse a trattamenti senza i quali si “muore subito” non ci sarebbe bisogno di suicidarsi, bastando la loro rinuncia. La delimitazione dei “trattamenti di sostegno vitale” all’alimentazione e all’idratazione forzata, alla respirazione artificiale e simili, sarebbe quindi irrazionale.
La sentenza 242/2019 della Corte costituzionale ha un senso, perciò, soltanto se si allarga la casistica delle ipotesi autorizzate a tutti i trattamenti, anche farmacologici, la cui assenza condurrebbe a un rapido peggioramento delle condizioni, fino a un esito letale o a una compromissione importante delle complicanze invalidanti.
Nel caso di Elena, la terapia a base di cortisone frenava una rapida e dolorosa progressione della malattia, impedendo il deterioramento incontrollato delle sue condizioni di salute. Tanto basta a considerarla una terapia salvavita e a ritenere la condotta di Cappato penalmente lecita. Senza quell’inutile umiliazione di doversi autodenunciare per un fatto che, pacificamente, non costituisce reato.